Di fronte alla guerra in Ucraina e a un contesto geopolitico sempre più instabile, la sicurezza del continente europeo si è imposta come una priorità strategica per i leader dell’Unione. Nelle ultime settimane, vertici straordinari a Londra e Bruxelles hanno portato all’adozione di nuovi impegni volti ad aumentare la spesa per la difesa e a rafforzare il sostegno all’Ucraina.
Tuttavia, in questo scenario di rapidi mutamenti, emerge un elemento cruciale che rischia di essere sottovalutato: il consenso dell’opinione pubblica. Il processo di riarmo del continente implica costi ingenti, e i cittadini europei non solo devono essere informati in merito, ma devono anche essere disposti ad accettare i sacrifici economici che ciò comporta.
L’assenza di un coinvolgimento diretto del pubblico potrebbe acuire il malcontento. In molti Paesi europei, gli elettori si sentono trascurati dopo anni di austerità e tagli al welfare, e un ulteriore aumento della spesa militare potrebbe esacerbare tali sentimenti, alimentando il consenso per le forze populiste, in particolare quelle di estrema destra con simpatie filorusse.
Le elezioni dell’ultimo anno hanno già evidenziato un avanzamento delle destre populiste in Paesi come Francia, Portogallo, Belgio e Austria. Una loro ulteriore affermazione rischierebbe di compromettere la stabilità europea in misura analoga a quanto l’attuale amministrazione statunitense sta facendo con gli impegni strategici degli Stati Uniti.
Nel corso dei decenni, i tentativi di costruire una politica di difesa comune europea sono stati ostacolati principalmente dal timore di indebolire la NATO e di incrinare i rapporti transatlantici. Di conseguenza, l’integrazione europea si è concentrata sull’ambito economico, presentandosi come un progetto di pace più che come un’alleanza militare.
Oggi, tuttavia, la crescente assertività della Russia e l’imprevedibilità del governo statunitense hanno reso inevitabile una revisione profonda di tale approccio. Con il tradizionale ombrello di sicurezza americano sempre più incerto, l’Europa si trova nella necessità di farsi carico della propria difesa. Difendere valori, interessi e cittadini richiede ora un impegno strategico concreto.
Fortunatamente, l’UE ha avviato un deciso cambio di rotta rispetto alla frammentazione del passato, un momento di svolta storica. Se in passato l’idea di una produzione e un finanziamento congiunto in ambito militare appariva utopica, oggi rappresenta una priorità strategica condivisa. Tuttavia, man mano che l’Unione si affranca dall’ombrello NATO, la posta in gioco politica si fa sempre più alta.
Il costo del riarmo e della modernizzazione della difesa impatterà direttamente sui cittadini europei, che storicamente hanno privilegiato la spesa pubblica per il welfare. Il ricordo delle politiche di austerità è ancora vivido, e solo nel 2024 la Commissione ha proposto tagli superiori al miliardo di euro a programmi fondamentali, prevedendo ulteriori riduzioni per oltre 100 miliardi al fine di rispettare i vincoli di bilancio. Un’ulteriore contrazione dello stato sociale rischia di colpire duramente una società già provata, rendendo politicamente complesso il consolidamento del consenso attorno all’agenda della difesa.
Un’indagine del European Council on Foreign Relations, realizzata a metà 2024, ha inoltre evidenziato come la maggioranza degli intervistati in Francia e Italia si sia dichiarata contraria all’incremento delle spese per la difesa, qualora ciò dovesse avvenire a scapito dei servizi sanitari e dell’istruzione.
Tali percezioni, però, precedono il ritorno di Donald Trump alla presidenza statunitense e la conseguente intensificazione della sua retorica ostile verso l’UE. Il mutato scenario internazionale potrebbe ora spingere i cittadini europei a rivalutare le priorità strategiche, rendendo più accettabili i sacrifici legati al rafforzamento della sicurezza.
Per far sì che ciò accada, la leadership europea dovrà elaborare una narrazione chiara e coinvolgente, capace di spiegare l’urgenza geopolitica della situazione attuale e la necessità dei compromessi richiesti. Senza un dialogo trasparente e costruttivo con l’opinione pubblica, le ambizioni europee in materia di sicurezza rischiano di essere compromesse alle urne.
L’instabilità della politica americana introduce ulteriori incognite. Qualora Trump dovesse improvvisamente modificare la sua posizione nei confronti della NATO, l’intero progetto di autonomia strategica europea potrebbe entrare in una nuova fase di incertezza. Tuttavia, al momento, la NATO appare sempre più marginalizzata, mentre Trump mantiene una posizione critica nei confronti dell’alleanza e mostra indulgenza verso il presidente russo Vladimir Putin.
In assenza di garanzie solide da parte di Washington, l’architettura di sicurezza transatlantica continuerà a subire profonde trasformazioni. L’automatismo nei flussi di forniture militari dagli Stati Uniti verso l’Europa non può più essere dato per scontato. Con l’UE determinata a sviluppare una propria base industriale per la difesa, è prevedibile una crescente competizione tra produttori europei e americani nei mercati globali.
Tutto ciò potrebbe condurre l’Europa a riemergere come potenza militare autonoma per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma affinché questa trasformazione si compia, sarà imprescindibile ottenere un ampio consenso elettorale. I cittadini europei dovranno decidere se intendono sostenere i costi necessari per definire il proprio futuro strategico, oppure correre il rischio di subirne le conseguenze.





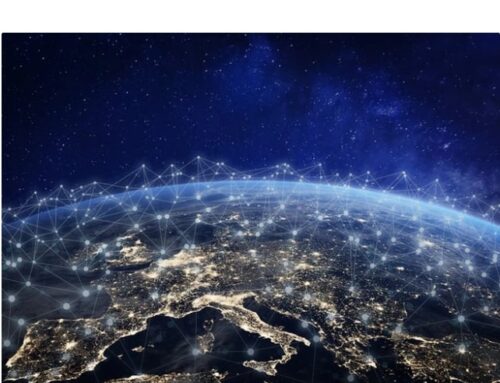
Scrivi un commento